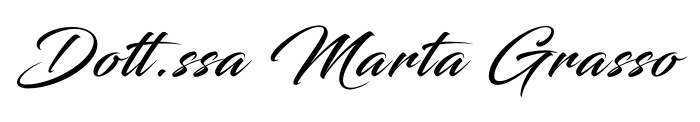Esiste un dolore che tutti conosciamo e che non è uguale a nessun altro: il dolore della perdita che è connesso alla fine, alla rottura, a qualcosa che si spezza o si interrompe definitivamente. Che sia la vita di una persona cara, o un capitolo della propria vita, un legame significativo o più spesso una relazione sentimentale, il dolore della perdita si fa sentire e riconoscere chiaramente.
Quella della fine o della perdita è un’esperienza che accomuna tutti gli esseri umani, grandi e piccini, dal nord al sud del mondo. E il dolore per la fine di una relazione è l’esperienza di perdita più comune e frequente, fra quelle vissute più intensamente, tanto che da millenni continua ad ispirare artisti di ogni genere.
Qualunque siano i motivi per cui ci si lascia, la fine di un rapporto è sempre dolorosa. Si tende a credere che chi pone fine alla relazione sia meno affranto, ma ciò non corrisponde quasi mai al vero: più spesso, semplicemente, chi lascia ha fatto i conti con la fine ed elaborato il dolore ad essa connesso prima dell’altra/o partner.
Il dolore della perdita è inizialmente pervasivo, può togliere il fiato, priva la persona di energie, demotivarla rispetto a tutto ciò che prima destava il suo interesse.
Talvolta la prima reazione è di rabbia, che è solo l’altra faccia del dolore; altre volte la collera si fa spazio solo in un secondo momento, preceduta da un periodo di buio, di svuotamento e smarrimento.
La rabbia è un sentimento irruente e chiassoso, spinge a reagire, spesso in modo inadeguato, ma muove all’azione e nel fare questo copre l’angoscia e il senso di perdita, rendendoli più tollerabili. Robert Emery, uno psicologo britannico che si occupa prevalentemente di separazioni, usa nei suoi testi una metafora a mio avviso efficacissima: quella dello spigolo.
A chi non è mai capitato di urtare il piede, possibilmente il quarto dito, contro lo spigolo di un mobile? Il dolore è acuto e lancinante, toglie il fiato; imprecare è sempre la prima reazione. E ciò perché imprecare, maledire, urlare con rabbia, dire parolacce, insomma infuriarsi lenisce il dolore, quanto più questo è violento.
Ma se la rabbia è fisiologica e funzionale, perchè aiuta a non sentirsi sopraffatti, provare dolore è necessario.
Attraversare il dolore della perdita, descritto così vividamente da Elena Ferrante nel romanzo “I giorni dell’abbandono”[1], passare attraverso allo smarrimento, alla perdita di senso, al vissuto di inutilità, confrontarsi con un sentimento di fallimento, di svuotamento, di ingiustizia, con la sensazione che nulla abbia più il peso o il valore che aveva un attimo fa, tutto questo è necessario perché il cuore guarisca. E’ difficile, talvolta appare insostenibile, ma necessario.
Di fronte all’immobilità dell’animo che il dolore induce, si sente l’urgenza di uscirne e di reagire, di porre fine all’angoscia, di bypassare la terribile fase che io chiamo “dell’abbrutimento”. Così ci si impone di uscire, di svolgere delle attività, di riprendere con le consuetudini quotidiane, e quant’altro, senza tuttavia mai trarne un vero sollievo o giovamento. A quel punto si rincara la dose e l’agenda si infittisce di impegni, che alla fine aggiungono solo ulteriore frustrazione e ulteriore peso.
“Cos’altro devo fare, allora?” mi chiedono le persone che seguo in terapia.
La risposta, la mia ricetta, è sempre una: “bisogna che si abbrutisca”.
Ciò desta sempre sorpresa, quando non iniziale diffidenza, ma alla fine si rivela sempre efficace.
Abbrutirsi vuol dire non contrastare il dolore della perdita, lasciarsi attraversare, a tratti sovrastare da questo, significa resistere al timore di soccombere all’angoscia. Abbrutirsi vuol dire autorizzarsi a sentirsi affranti, svuotati, senza più orientamento, pesanti, lenti.
Abbrutirsi significa accettare di non avere voglia di uscire, parlare, adempiere alcuni impegni, vestirsi, mangiare sano.
Non esiste un vademecum dell’abbrutimento. Ognuna ed ognuno si abbrutisce come può e come vuole. C’è chi resta in pigiama per un giorno intero, chi non studia per l’esame all’università, chi mangia 1 kg di gelato, chi solo pizza perché non ha voglia di cucinare, chi guarda film tristi, chi ascolta canzoni deprimenti, chi non smette di piangere, chi telefona agli amici per ripetere le stesse cose come un disco rotto, chi guarda ossessivamente vecchie foto, chi si trascina a lavoro con i capelli arruffati, chi non scambia una parola con nessuno.
Non esistono ingredienti fissi; quello che conta, perché la ricetta riesca, è che la persona assecondi il proprio stato d’animo e attraversi – lasciandosi attraversare da esso – il dolore della perdita.
Contrastare il proprio bisogno di abbrutimento non fa che alimentare la frustrazione e rende tale bisogno ancora più vorace. Spesso si ha paura di cedere alla tentazione di lasciarsi andare al dolore, perché si teme di soccombere ad esso, rendendo più dura la ripresa.
Ma è vero l’esatto contrario, perché è solo ascoltando i propri bisogni e dando diritto di cittadinanza ai propri sentimenti, soprattutto quelli più difficili da trattare, come è sempre il dolore, solo in questo modo è possibile davvero elaborare la perdita e ricominciare a vivere.
NOTE
[1] Elena Ferrante, 2002, I giorni dell’abbandono, Edizioni E/O
[2] Olio su tela di Frida Kahlo, “Ritratto con capelli tagliati”.
Nel 1940, a seguito dell’ennesimo tradimento da parte del marito, la sua relazione con Diego Rivera si concluse. Frida reagì tagliandosi i capelli e smettendo di indossare il costume da tehuana tanto caro al marito. Nel dipinto, che documenta questo evento, ella si ritrasse vestita da uomo, con i capelli corti e le forbici in mano, come a voler simboleggiare il vuoto di passione, femminilità, seduzione ed energia vitale legato al dolore della perdita.
Mi piace pensare a questo come all’autoritratto dell’abbrutimento della pittrice.